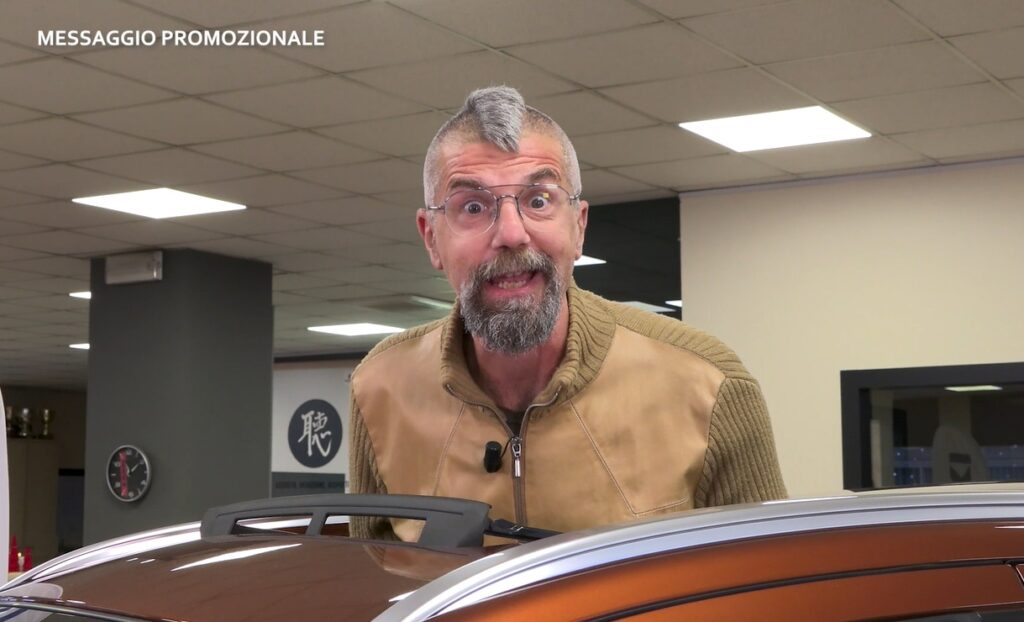“La morte dell’arte”.
Così la definisco io questa ricerca spasmodica del “buono e del giusto” (che non sono sinonimi ed è bene ricordarlo sempre).
Un tempo si chiamava “politically correct”, ma adesso la definizione appare francamente riduttiva.
Per chi fa un mestiere come il mio questa forzatissima canalizzazione dei concetti sdoganabili rappresenterebbe l’annullamento, prima ancora che delle idee considerate “sbagliate”, della possibilità di poterle personalizzare, lavorare, queste idee, distinguendo magari, in siffatta maniera, l’artista vero da quello da due soldi e ancor più dal rozzo creatore di semplici, terribili, grossolani slogan.
Uso il condizionale perché in realtà sappiamo bene quanto la mia categoria sia permeata da una miriade di paraculi inqualificabili che ostentano morali che semplicemente non hanno, pronti peraltro a cambiarle non appena cambia il vento che porta loro vantaggi.
Comunque, tanto per non perdere il filo del discorso: mille categorie sensibili, mille fasce protette e sempre più cose che “non si possono più dire” né pensare (ma l’AI arriverà a sgamarci pure lì, tranquilli), nemmeno per scherzo.
Che poi, fuori dai denti, in alcuni casi non si scherzerebbe nemmeno, se solo avessimo la fortuna di poter parlare con persone intelligenti.
Quace ‘mbecilli che gh’è al mónt, invece! M’ai fàcc chè de mal nóter per soportài töcc?
Una brutta canzone sulla pace nel mondo, secondo me, vale la metà di una bella canzone su, che ne so, quanto è stato bello fare la cacca quella volta in cui l’abbiamo tenuta a lungo e abbiamo rischiato di insaccarla nelle braghe.
Conta di più il “come” del “cosa”, sempre, secondo me, quando si ha la pretesa di parlare di arte. Anzi, se ci pensiamo bene, è proprio quella, l’arte! Se così non fosse basterebbe scegliere un argomento serissimo per scrivere ogni volta un insindacabile capolavoro.
“Mé ga próe a dì de no, mé ga próe a tiràm fò” (“Ol pedriöl”, album “T11” – 2018, tanto per autocitarmi), ma non è facile se ogni volta dobbiamo passare da chi è terrorizzato dalle forche caudine dei rompicoglioni.
Capita ch’io proponga in giro cose nelle quali la mia (presunta) bravura starebbe proprio nel lavorare di fino, nel fare in modo che certi concetti siano magari interpretabili, ma alla luce di verità oggettive sotto gli occhi (e le orecchie) di tutti.
La bravura di un artista potrebbe pure stare, perché no, nella sagacità del tirar fuori in maniera deliberata quello che non si dovrebbe; così, senza nemmeno un vero perché, come un fulmine a ciel sereno, strappando sicuramente un sorriso, qualora si sappia dosare bene la malizia che consente di rimanere al di qua della linea, senza offendere (almeno platealmente) nessuno.
Non tanto perché non sarebbe opportuno farlo (va beh…anche), quanto perché la cosa rappresenterebbe quasi sempre un impoverimento dell’opera, un passo falso da un punto di vista artistico.
Ci sono argomenti che fanno ridere anche solo per essere stati affrontati, in fondo.
“No. Qualcuno potrebbe averne a male.”
Ecco, lo si può anche sfanculare questo qualcuno o no?
O l’ ga sèmper resù lü e nóter an ga sèmper de fa sito?
“No. Qualcuno potrebbe averne a male.”
Mi hanno detto che il Gioppino adesso convince i cattivi con le parole (ma deve comunicare prima quali all’apposita Commissione di Vigilanza) e non più con le vecchie, sonore, meravigliose, violentissime, diseducativissime bastonate.
Splendido, giusto, corretto, formativo…inclusivo Gioppino!
E il bastone, che non gli serve più, stia bene attento a non bruciarlo (multa salata) o a buttarlo nel cassone sbagliato.
Va bene. E allora ascoltatevi “La pancia della gente” (album “Da10me” – 2017), giusto per non lesinare immodeste e distopiche autocitazioni.